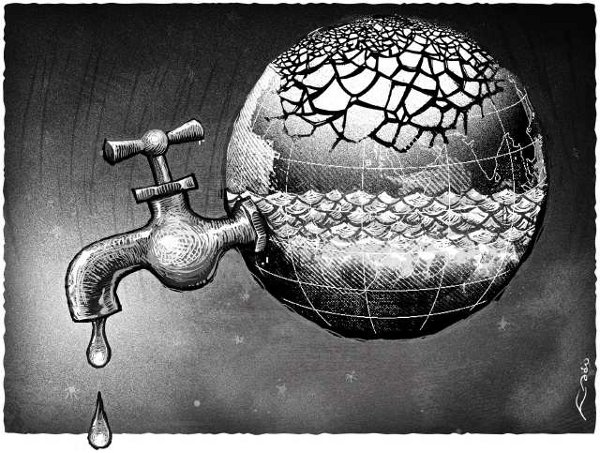
OMNIA SUNT COMMUNIA: SPAZIO POLITICO E BENI COMUNI
PENSARE IL COMUNE
Pur riconoscendo le potenzialità
politiche di una relativa indeterminatezza semantica del termine “comune”
(indeterminatezza che in un certo senso permette di stabilire un tessuto
connettivo tra lotte sociali disparate – acqua bene comune, salute bene comune,
sapere bene comune – creando, si spera, un fronte unico di movimento), vorremmo
qui esplorarne alcune implicazioni concettuali, lavorando più per somiglianze
di famiglia che per definizioni di essenza.
Innanzitutto, un lavoro del
genere può essere utile per iniziare a delineare una teoria giuridica dei beni
comuni. In questa direzione, provare a dare una definizione più rigorosa a
riguardo potrebbe avere i suoi motivi d’interesse. Cosa distingue un “bene
pubblico” o un “bene privato” da un “bene comune”? E, andando anche oltre il campo più prettamente giuridico,
come distinguere il concetto stesso di “bene” da quelli di “diritto” e di
“risorsa”? Perché, ad esempio, nel gergo tecnico (ma anche nel senso comune) l’acqua
è passata da “bene” a “risorsa”? Quali cause hanno determinato questo
slittamento semantico, e quali effetti (economici soprattutto) ha avuto?
Questa domanda solleva il
problema della performatività di una definizione del “bene comune”. E cioè: i
beni comuni sono tali in sé, intrinsecamente e, per così dire, ontologicamente?
O dipendono invece dallo statuto discorsivo che le pratiche di determinati
soggetti politici gli attribuiscono? Il sapere, ad esempio, può essere
considerato un bene comune prima che un certo movimento sociale o politico
(pensiamo alla mobilitazione dell’Onda, o ai movimenti indigeni di
riappropriazione dei saperi tradizionali espropriati dalle corporation
multinazionali) lo rivendichi come tale? E, eventualmente, quale soggetto politico
(movimenti, reti di cittadini, partiti…) può e deve farsi carico di questa
rivendicazione? Con quali strategie?
Oltre a queste differenze
“esterne”, nel discorso politico o scientifico sul tema dei beni comuni si
affacciano spesso distinzioni “interne”. La rete di movimenti che si è venuta e
si sta venendo a creare attorno al nodo dei beni comuni, ha messo a tema tanto
la difesa di beni “naturali” o materiali come l’acqua, quanto quella di beni
“artificiali” o immateriali come il sapere. Come trarre sapere da questa
intuizione? Come tenere insieme beni comuni resi disponibili dalla natura e
beni comuni frutto delle interazioni e delle produzioni umane, per non ricadere
in vieti dualismi del tipo natura/cultura? Su questa distinzione, si ricalca quella
tra conservazione e produzione del bene: il comune, si dice, non deve essere
solo luogo di conservazione dei beni, ma anche di produzione di “eccedenze”,
come se i due aspetti rappresentassero in qualche modo delle istanze
contrapposte. Esiste, ci chiediamo, una prospettiva in grado di superare anche
questa dicotomia?
Infine, il comune può e deve
essere inteso anche come una configurazione nuova dello spazio politico. Lo
spazio politico (pubblico) moderno è, quasi per definizione, uno spazio
striato: frontiere, confini, mura, porte. Come immaginare allora lo spazio
comune, se è vero che esso rivela a pieno le sue potenzialità proprio a partire
dalla crisi sia dello spazio pubblico che di quello privato? Semplicemente come
uno spazio liscio? O come spazio percorso da nuove striature? Quali potrebbero
essere le topografie politiche del comune?
GENEALOGIE DEL COMUNE
Lungi dal collocarsi in un lontano orizzonte utopico, come mero
dover essere separato dalle pratiche concrete, il comune è una dimensione che ha
profondamente a che fare con una prospettiva storica. In effetti, se ci
volgiamo al passato, possiamo constatare come la gestione collettiva di beni
comuni vanti una tradizione plurisecolare che non solo affonda le sue radici
nel mondo pre-moderno ma che sopravvive in piena (e forse ormai post) modernità
(pensiamo ad esempio al caso italiano degli usi civici). Che ruolo può giocare
allora una ricostruzione genealogica delle pratiche del comune? Come
riattivarle al presente, senza scadere però nel rimpianto romantico di un mondo
(idealizzato) che non c’è più, o quasi più?
Lo strumento genealogico può
essere innanzitutto fatto giocare come istanza rivendicativa contro il
monopolio dell’ideologia moderna della proprietà privata individualistica. E
questo tanto più quanto le stesse teorie moderne della proprietà privata si
costruiscono a loro volta come genealogie. Locke, ad esempio, passava quasi
senza soluzione di continuità dalla proprietà di sé e del proprio corpo
all’appropriazione delle cose esterne. Ora, questa genealogia proprietaria non
è neutra, ma sessualmente segnata: il suo punto di partenza, il rapporto di
proprietà nei confronti del proprio corpo, ne denuncia l’appartenenza ad un
orizzonte esperienziale maschile. Forse ne è prova anche il fatto che, lungi
dal costituire la pietra d’angolo di un ordine individualistico e atomistico,
la rivendicazione femminile di una sorta di habeas
corpus (pensiamo all’“Io sono mia” del movimento delle donne negli anni
’70) ha funzionato da movente di liberazione e aggregazione politica. È
possibile allora disegnare genealogie diverse? È possibile, attraverso saperi
tradizioni e pratiche diverse da quelle maschili imperanti, ripensare il
rapporto tra uomo/donna e cose in senso relazionale e non esclusivo/escludente?
Le genealogie permettono anche di
costruire preziosi, benché problematici, parallelismi. Uno dei fenomeni più
spesso notati è ad esempio l’analogia tra i processi di recinzione delle terre
comuni (enclosures) che si svolsero
in Occidente all’inizio della modernità (e che anzi ne rappresentano forse uno
dei momenti originari), e i recentissimi processi di “recinzione” dei saperi e
delle conoscenze, che il capitalismo “cognitivo” opera attraverso politiche
aggressive di copyright. Tuttavia, al di là delle innegabili somiglianze, in
questi processi sembrano delinearsi due movimenti distinti, a seconda che si
tratti di beni materiali o immateriali. Nel primo caso l’esproprio è passato
attraverso un annullamento del diritto precedente (il diritto tradizionale
medievale), che ha permesso l’istituzione della dicotomia moderna di
pubblico/privato – dicotomia sciolta poi a favore del secondo polo, quello
privato (privatizzazioni di beni pubblici e dei beni comuni). Si tratta quindi
in un certo senso di una deregolamentazione, che ha consentito una (presunta)
maggiore libertà dei soggetti economici – nascita dell’homo oeconomicus. Nel caso di beni immateriali invece vediamo un
movimento opposto, dove il diritto, invece che ritirarsi, funge proprio da
strumento aggressivo di recinzione del sapere-bene comune. Qui la tendenza è
quella opposta alla deregolamentazione, in favore della creazione di continui e
nuovi confini (i copyright) che
favoriscano lo sfruttamento e la messa a valore dei nuovi beni comuni.
Come spiegare questa differenza?
Si tratta solo di una distinzione tra beni materiali e beni immateriali? Siamo
di fronte ad un mero ripetersi della storia delle enclosures di qualche secolo
fa, al ritorno di un identico modello di accumulazione originaria di cui variano
soltanto i contenuti (elementi naturali da una parte, saperi umani dall’altra)?
Se è così non si sta forse pensando all’interno di una specie di immobilismo (o
idealismo) storico? Il capitalismo è rimasto uguale a se stesso? O, in caso
contrario, come pensarne la discontinuità rispetto al tema dei beni comuni?
Infine, per ora abbiamo parlato
di genealogie “temporali”. È possibile tracciare anche genealogie “spaziali”
del comune? Ad esempio, se è vero che la città si organizza attraverso linee di
confine (le mura) e passaggi (le porte), è anche vero che la sua struttura
prevede spazi di aggregazione comune (le piazze, ma non solo) che non sembrano
rientrare né nella categoria di confine (la piazza non include/esclude,
accoglie) né in quella di passaggio (la piazza come punto di raccolta, anche se
provvisorio). Come pensare questa differenza, soprattutto nel momento in cui la
città sembra dover lasciare il posto alla metropoli o al “territorio”?
ISTITUZIONI DEL COMUNE
Se è vero che il comune (e la difesa dei beni comuni) si dà soprattutto
nelle pratiche politiche di relazione, è anche vero che queste pratiche spesso
non hanno in sé una durevolezza tale da permettergli di sopravvivere alle
singolarità o ai gruppi che le animano. Questo solleva il problema di come
trasformare queste pratiche in “istituzioni” (intese qui in senso ampio, quali
fattori di continuità nel tempo), senza però ipostatizzarle o cristallizzarle
in Istituti. Ma, ancora prima, è davvero necessario questo passaggio? Oppure
è più plausibile che il comune, dandosi solo
all’interno delle lotte politiche, come ciò che si strappa e si ottiene con la
radicalità di pratiche e discorso, sia meglio conservato/prodotto da una lotta
continua e ininterrotta diretta contro la voracità appropriativa del
capitalismo, senza tentare la via dell’istituzione?
Il sapere come bene comune offre
un buon esempio del tipo di problemi messi in campo. Conoscenza, sapere e
linguaggio sono dimensioni che si danno tutte nel “tra” della relazione: non
sono propri di una mente individuale e isolata, ma si configurano piuttosto
come elementi transindividuali. Ora, però, una loro “istituzionalizzazione”
solleva immediatamente diverse questioni. In effetti, la capitalizzazione delle
conoscenze viene spesso presentata come causa fondamentale e contemporaneamente
tra gli esiti ineludibili dell’istituzionalizzazione di un sapere. In questo
movimento di capitalizzazione, il processo conoscitivo viene a cristallizzarsi
in verità formalmente apodittiche, che formano un sapere perlopiù chiuso ad
ulteriori progressi epistemologici. Vi sono pratiche di sapere che non sembrano
poter sottostare ad un simile logica e che non possono essere immesse nelle
forme istituzionali di trasmissione del sapere se non a costo di pesanti rinegoziazioni.
Tali pratiche trovano infatti la propria collocazione in quel non-luogo
alternativo alla dicotomia pubblico/privato che è l’ambito del comune. Come può
allora realizzarsi una trasmissione nel tempo di simili pratiche di produzione
comune di sapere, una volta rifiutato l’ambito delle istituzioni ufficiali, una
volta rifiutato l’ambiente accademico e i luoghi codificati?
Il diritto, in questo campo, si
rivela un arma a doppio taglio. Se, da un lato, potrebbe essere possibile
pensare ad una tutela giuridica del sapere come bene comune, dall’altro le
nuove enclosures operate dal capitale cosiddetto cognitivo operano proprio
tramite brevetti e “diritti d’autore” (copyright).
In effetti, il tema dei brevetti (e per estensione del copyright) è uno dei temi
più spinosi e più spesso affrontati in questo campo d’indagine. Se la
conoscenza deve davvero essere un bene comune, non possiamo accettare alcun
tipo di “recinzioni” che impediscano la libera fruizione di informazioni,
relazioni e conoscenza. Eppure, in ambito economico (e mi riferisco economia main stream), sembra che il concetto di
“brevetto” sia qualcosa d’imprescindibile: un brevetto è infatti considerato
come un incentivo e un riconoscimento del lavoro svolto, e per questo qualcosa
di strutturale e di irrinunciabile. È vero altresì che sulle tematiche del
“diritto d’autore” c’è davvero molta confusione. Facciamo un esempio concreto:
un’opera letteraria (che Hegel definirebbe – fin quanto a torto? –
estrinsecazione dello spirito dell’autore). Sappiamo (e qui le stime sono
approssimative ma concrete) che il così detto “diritto d’autore”, lungi dal
rappresentare una tutela reale per l’autore, è fonte di guadagno soltanto per
le sovrastrutture che ne gestiscono immagine e idea: di un’opera (il discorso non
cambia per le opere letterarie o musicali; per i software invece le stime sono
leggermente differenti), infatti, un autore non acquisisce mai più del 5-8% dei
ricavati. Il “rimanente” degli utili è quindi ripartito tra casa
editrice/discografica (45-50%), promozione e diritti di immagine (8-10%),
distribuzione (10-15%), e punti vendita (30%). A fronte di tali stime, possiamo
ben capire perché l’“industria culturale” sia così riluttante a negare
qualsiasi tipo di “liberalizzazione”, e di contro esiga il perpetrarsi di un
tale frazionamento economico/commerciale. Eppure la questione brevetti non è
stata ancora messa a tema adeguatamente: anche se forse è impossibile
rinunciare a un riconoscimento di un certo legame intellettuale tra l’autore e
la sua opera (da Locke alla provocazione del “copyleft”, il tema del lavoro
svolto è sempre messo in luce come fattore caratterizzante), non si può neppure
considerare l’ingegno personale come totalmente isolato, indipendente dal resto
del general intellect. Ora, è possibile non interpretare questo legame nei
termini tradizionali della proprietà privata? O piuttosto, lungi dal
rivendicare un’abolizione radicale del concetto di brevetto e di proprietà, non
sarebbe forse più plausibile semplicemente slegarlo dagli ambiti del mercato,
liberalizzandone cioè la fruizione e la possibilità di scambio?
Torniamo per un attimo sul tema del diritto. Una delle soluzioni
per introdurre nell’ordinamento giuridico la categoria di “beni comuni” è
quella di legarla alla soddisfazione di diritti considerati fondamentali. Ora,
come si colloca questa proposta rispetto alle critiche avanzate da più parti
alla grammatica universalista dei diritti? Non c’è il rischio, ad esempio, che
definire qualcosa di “fondamentalmente” umano possa risultare una pratica
discorsiva normativa? Come evitarlo? Esistono forme di bene comune che si
collocano su un piano diverso, che cioè non permettono una rivendicazione in
termini di “diritto fondamentale”?
E ancora: una teoria giuridica
dei beni comuni ha evidenti potenzialità politiche, non fosse altro che per
sottrarre una certa quantità di beni alle leggi del mercato e alle logiche
neoliberiste di privatizzazione totale dell’esistente. Ma è possibile che il
diritto, oltre a questa funzione positiva, nasconda anche un “lato oscuro”? Che
possa essere usato (o che sia già stato usato) anche per favorire le operazioni
di predazione dei beni comuni da parte del capitale globale? Come pensare
allora un “altro diritto”?
E tuttavia, il giuridico non è
l’unica modalità in cui sia possibile declinare il tema delle “istituzioni” del
comune. Un’altra prospettiva interessante in questo senso potrebbe venirci
dall’architettura. In effetti, nei paesi scandinavi si danno ormai molteplici
esempi di condomini progettati e costruiti prevedendo la presenza di luoghi di
produzione comune (laboratori, forni, sale riunioni) per i condomini – oltre
alle abitazioni private. È possibile allora che un certo tipo di organizzazione
spaziale possa fungere da elemento di “istituzionalizzazione” (nel senso
suddetto di un conferimento di continuità nel tempo) delle pratiche del comune?
Che, insomma, la creazione di spazi comuni (né pubblici né privati) possa
essere condizione – non certo sufficiente – per la produzione durevole di
comune? In caso affermativo, come pensare questi spazi?
(AUTO)GESTIONE DEL COMUNE
La commissione Rodotà, incaricata
nel 2007 di redigere un disegno di legge delega per la riforma delle norme del
codice civile in materia di beni pubblici, ha sottolineato a più riprese la
necessità di porre il bene comune su un piano giuridico che non sia
immediatamente ascrivibile né al diritto pubblico né al diritto privato. In
alcune interviste lo stesso Rodotà pone la questione con determinatezza,
ritrovando nell’art. 43 della Costituzione della Repubblica Italiana una
soluzione. Così recita l’articolo: “A fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale”. In particolare viene sottolineata
la possibilità di “riservare originariamente o trasferire […] a comunità di
lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese”. Sotto
questo profilo la gestione del bene comune potrebbe essere affidata
direttamente alle varie comunità locali. Quale potrebbe essere allora il
profilo giuridico di una “azienda speciale” che gestisca il bene comune? Quali
strumenti per attuarla e concretizzarla? Quali sono i passaggi politici
necessari per ottenere tale gestione, né pubblica né privata, del bene comune?
Può essere considerata una forma di “democrazia partecipata”?
C’è di più. La giustificazione
che spesso viene addotta per le varie proposte di privatizzazione (pensiamo ai
recenti tentativi di privatizzazione dell’acqua, o meglio delle “risorse”
idriche), è che esse non riguardano il bene o la risorsa in quanto tale, ma la
gestione che ne deriva. Nelle tautologie del “sentito dire” sta così passando
l’idea che un bene, pur gestito privatamente, possa rimanere pubblico (qui la
definizione di “pubblico” cozza nuovamente con la nozione di “comune”); ma fin
quanto questo è possibile? La gestione stessa non riguarda già la libertà o la
disponibilità di un dato bene? Che caratteristiche dovrebbe avere invece la
gestione collettiva (in quanto distinta dalla gestione pubblica) di un bene
comune? Tornando all’esempio dell’acqua (ma tralasciando la questione pur pregnante
delle infrastrutture): come si potrebbe delineare una gestione propriamente
afferente al comune? Non ci sarebbe a questo punto anche da ridefinire giuridicamente
le peculiarità stesse della “comunità”?
In effetti, uno dei punti di
forza del tema dei beni comuni, ciò che gli permette di costituirsi come piano
altro rispetto alla tenaglia pubblico-privato, è il suo legame con la comunità
e le sue capacità di autogestione e autogoverno. Tuttavia, la comunità è un
oggetto ambiguo, giocato solitamente sul crinale tra inclusione dei propri
membri ed esclusione delle e degli esterni, delle e degli “extracomunitari”. È
possibile pensare la comunità senza questo meccanismo di inclusione/esclusione?
O, in alternativa, come svincolare i beni comuni dal loro legame con la
comunità, mantenendone però intatte le potenzialità?
Inoltre, le risorse non sono
distribuite in modo omogeneo sul territorio. Rispetto ad un certo bene (acqua,
elettricità, terra, ecc.) alcune comunità potrebbero trovarsi in situazioni di
abbondanza, altre in situazioni di scarsità. Come assicurare allora la
necessaria redistribuzione? C’è forse comunque bisogno dell’intervento
pubblico/statale, o anche in questo caso è possibile trovare soluzioni di
governance partecipata e “dal basso”?
Fin qui ci siamo concentrati su beni cosiddetti
“materiali”. Ma il comune si dà anche nell’immaterialità (anche se il termine
non è certo il più adatto) delle relazioni, delle interazioni sociali, nelle
eccedenze di pratiche e saperi prodotte dalla cooperazione umana. Per questo
tipo di “bene comune”, parlare di gestione privata sembra perdere quasi ogni
senso. Tuttavia, l’apparente impossibilità di vincoli privatistici, che sembra
prefigurare un paradigma di costruzione della realtà connotato in chiave
comune, reciproca, collettiva, rischia forse di risultare funzionale alle
esigenze produttive del capitalismo cognitivo post-fordista. In altre parole, è
possibile che anche il comune “immateriale” sia gestito a vantaggio di capitali
privati? In questo senso, quanto una riflessione (anche giuridica) sui beni
comuni deve tenere conto di queste appropriazioni da parte dell’interesse
privato di esternalità prodotte dall’interazione comunitaria e sociale,
soprattutto nel caso in cui vengano messi a profitto funzioni immateriali del
comune (saperi, pratiche, relazioni collettivamente declinate)? Che tipo di
sorveglianza critica impone, soprattutto al singolo (conteso tra esperienze
collettive dello spazio comune e esperienze individualizzanti del rapporto con
il potere economico), il pericolo di questa trasferibilità non immediatamente
visibile? Come sottrarre, nell’epoca della sussunzione reale di tutto il tempo
di vita al capitale, spazi di agibilità e di produzione di comune non
riassorbibili dalla logica del profitto?
