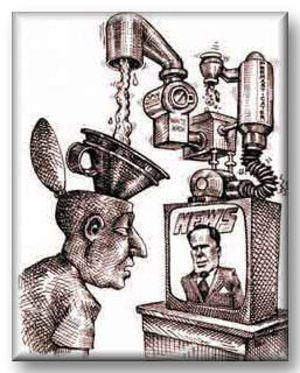
MICROFISICA DEL DISCORSO. LINGUAGGIO E POTERE NELL’ERA DELLA MEDIAZIONE GLOBALE
Il potere si esercita anche
tramite il controllo e la produzione e riproduzione dei segni e dei linguaggi.
La questione del linguaggio, sia esso inteso come lingua parlata o come insieme
di segni più in generale assume quindi una posizione centrale per qualsiasi
discorso politico.
In questo senso, il nesso tra
verità e linguaggio è evidentemente uno dei nodi fondamentale che un discorso
politico dovrebbe impegnarsi a districare. Tra essere e linguaggio esiste una
relazione reciproca. Non esiste un mondo di significati da una parte, ed un
mondo significato (il mondo “reale”) dall’altra – mondi tra cui una relazione
interverrebbe solo in un secondo momento: esiste un solo mondo, in cui questi
due (che presi separatamente non sono altro che astrazioni), sono in circolo ab origine. Il che vuol dire che senza
essere non c’è linguaggio, ma anche che senza mediazione linguistica non si può
arrivare all’essere: la mediazione è necessaria. Assumendo questa prospettiva,
il linguaggio non può più essere considerato come meramente descrittivo, la
verità non può più essere definita come “adaequatio rei et intellectus”; piuttosto, il suo è un ruolo
altamente performativo: il problema della verità diventa allora centrale. Come pensare la “forza della
verità” senza utilizzare un modello “corrispondentista”? Se il linguaggio è
visto solo come uno strumento per “fare cose con le parole”, non si rischia di
scadere nel relativismo politico? Non si corre il pericolo di essere costretti
a dire che non esistono discorsi veri e discorsi falsi, ma solo discorsi più o
meno efficaci (ammettendo perciò che l’efficacia possa premiare, come di fatto
a volte succede, discorsi populisti, sessisti, razzisti)? Roland Barthes
diceva che la verità è a sinistra: possiamo ancora dirlo? E se sì, come?
Forse ingenuamente si crede che la verità abbia in
sé una forza tale da affermarsi nonostante tutti i tentativi di impedirlo –
come se possedesse una potenza intrinseca che nessun ostacolo in senso
contrario può arrestare. Eppure, nelle recenti vicende politiche abbiamo esempi
discordanti. Prendiamo i casi limite di Aznar e Bush: il primo mente, viene
scoperto, e la sua menzogna gli causa una inaspettata sconfitta elettorale; il
secondo mente (e fa mentire) spudoratamente sulle armi di distruzione di massa
in Iraq, il suo inganno ad un certo punto risulta evidente, e tuttavia viene
rieletto con relativa tranquillità anche per un secondo mandato. Come spiegare
questi risultati apparentemente opposti? Quali altri elementi, oltre alla
coppia verità/menzogna, possono entrare in gioco? È possibile che oggi, come
sosteneva Hannah Arendt, i linguaggi abbiano un potere performativo tale da
convincere anche chi proferisce una menzogna palese di stare dicendo la verità?
Si può parlare di autoinganno e quindi di nuovo appellarsi ad una verità
effettiva contro un proliferare estremo di linguaggi? Quanto della forza
performativa dei linguaggi è strettamente legata alla condizione storica che ci
troviamo a vivere?
E’ poi necessario introdurre un discorso sui mass
media contemporanei. La società in cui viviamo è talmente permeata dalla
presenza di mezzi di comunicazione di massa tecnologici capillari e invadenti
che discutere sul tema del linguaggio prescindendo da essi sarebbe un
controsenso.
Assumendo che i media non sono mai neutri e considerando
che la grande maggioranza della comunicazione è operata attraverso questi
strumenti, la possibilità di controllo appare enorme.
Tuttavia sembra che il potere
si rapporti al linguaggio, si strutturi su di esso, in una maniera particolare.
Non più secondo la tradizionale immagine del potere che “dispone” del mondo.
Piuttosto utilizzando linguaggi pre-costituiti, costituiti altrove, accumulati.
Si potrebbe ragionare di una rarefazione dei poteri in quanto a controllo e
disposizione dei linguaggi la quale però non mini la loro capacità di
manipolazione del corpo sociale. Il potere smette di fare riferimento ad una
volontà imperativa unitaria, ma piuttosto si gioca sui piccoli margini di
spostamento del senso delle sezioni di linguaggi già presenti nella mediazione
linguistica generale. In questa ottica sembrerebbe che la tecnica linguistica
dominante sia la post-produzione, la tessitura discorsiva nel suo complesso è
fatta di flessioni. Il senso su cui ragionare è che c’è un universo di
significati, autonomi, prima dei poteri, che sfruttano il potere già annidato
nei linguaggi, piegandolo a un più-di-potere locale. Il rischio di un controllo capillare, di un grande
fratello orwelliano, di uno scenario dominato da una riproduzione senza
produzione (per usare i termini deleuziani) è ancora plausibile in questo
panorama, oppure i meccanismi di controllo sono differenti? Se sono differenti
quanto in questo mutamento è dovuto al proliferare di linguaggi e codici e
mezzi di comunicazione di massa?
D’altro canto, dal punto di vista di un soggetto, è
corretto pensare che, posto che la nostra produzione/creazione
concettuale in relazione a un segno esterno sia comunque già data e veicolata,
la tendenziale onnicomprensività del linguaggio, la saturazione di segni e
informazioni caratteristica della nostra società, inibisca una
riflessione/elaborazione propositiva e personale? Che spazio viene lasciato ai
soggetti? E se la ricezione critica è davvero strutturalmente impedita, come
possiamo ripensare pratiche politiche come quella di “guerriglia semiologica”
proposta da Eco, basata proprio sull’idea di contestare i messaggi là dove essi
arrivano (senza perciò cercare di cambiarli alla fonte)?
Il potere agisce quindi per ri-traduzione e
ri-proposizione di linguaggi già costituiti altrove. Questo potrebbe coincidere
con una tendenza alla codificazione operata dal sistema, la quale produce una insignificanza
che svuota qualsiasi linguaggio della propria forza produttiva. Questa insignificanza
genera un depotenziamento della verità stessa che, nel discorso politico, è
diventata inefficace, dato che tutti i discorsi si equivalgono ed ogni verità è
sempre declassata a mera opinione. In questa condizione è pensabile una
strategia di resistenza basata sulla “risignificazione” dei linguaggi? Ritornando
al tema iniziale, costruire azione politica sulla risignificazione in che
misura comporta un abbandono della “verità” come guida per un’azione politica
efficace?
Parlavamo prima della necessità della mediazione.
Ora, per il pensiero della differenza, la prima e fondamentale
mediazione ci è offerta dalla madre (o chi per essa), che ci dà insieme vita e
parola: riconoscere l’autorità della madre darebbe origine all’ordine
simbolico, che è poi anche questo stesso circolo di linguaggio ed essere. Il
patriarcato ha cercato in tutti i modi di appropriarsi di questo doppio potere
materno, il potere di generare e di dar vita ad un ordine simbolico. Ora, si
dice, il patriarcato è in crisi. Tuttavia, sembra che il suo movimento
appropriativo continui; anzi, nell’epoca della globalizzazione, i media di
massa hanno fortemente potenziato il tentativo di monopolizzare la “necessaria
mediazione”. Il potere che gliene deriva, in termini di capacità di definizione
del reale, è enorme. Come far fronte a questo movimento? Come evitare che
l’autorità materna sia pervertita in autoritarismo mediatico? E, se è vero che
il patriarcato è in crisi, chi è allora il soggetto (o i soggetti) responsabili
– in senso lato – di questi tentativi di appropriazione, e contro il quale (o
contro i quali) bisogna opporsi?
Per ritornare al discorso dei
mass-media, è interessante osservare come il linguaggio politico che essi
veicolano suggerisca una specie di proporzionalità inversa tra qualità e
quantità. Se aumento la qualità del mio discorso, sembra
che inevitabilmente diminuisca la quantità dei/lle possibili "utenti"
di quel discorso. Viceversa, se abbasso la qualità, aumento la quantità di
chi può accedervi. Il primo corno del dilemma ci sembra ben rappresentato
da quel certo tipo di sapere critico "accademico" di qualità teorica
anche elevatissima, di radicalità forse altrettanto elevata, ma di difficile
accessibilità al lettore medio. Il secondo corno ci sembra invece riprodotto da
quel tipo di discorso politico che, per parlare a tutti/e, sceglie di non
parlare di nulla. Il che, in realtà, per un linguaggio politico risulta essere
un paradosso: perché la politica è sì quantità (un’azione politica non dovrebbe
mai essere una cosa elitaria), ma è anche qualità (quando si fa politica
si deve dire qualcosa; la superficialità non dovrebbe essere – e usiamo
il condizionale non a caso – politica). Quanto questa dicotomia è legata alla
non-neutralità dei media contemporanei, e cioè alla loro struttura intrinseca?
È
possibile allora rompere con questo schema consueto – quello appunto che mette
in opposizione qualità e quantità, intensione ed estensione? È possibile
conciliare partecipazione e sostanza (pratica, discorsiva, culturale)? Come
potrebbe configurarsi (o come si è configurato, quando vi è riuscito) un
linguaggio politico di questo tipo? Inoltre, tutto questo comporterebbe
necessariamente l’abbandono di un mezzo di comunicazione come la televisione i
cui linguaggi sembrano refrattari ad ogni possibile “profondità”?
Detto questo, come muta il
ruolo dell’informazione nel mondo contemporaneo? Il quasi monopolio mediatico
cui assistiamo in Italia può essere pensato come una distorsione legata alla
particolare figura del nostro presidente del consiglio, o è invece la stessa
struttura della società contemporanea, caratterizzata da una formazione di
opinione pubblica quasi totalmente mediata dai mezzi di comunicazione di massa,
che tende di per sé a ostacolare la possibilità di formare un’opinione pubblica
critica?
Un altro tema che ci
piacerebbe affrontare è il rapporto tra linguaggio e natura umana. In effetti,
già Aristotele definiva l’uomo come animale politico e dotato di linguaggio. Una ripresa recente dalla questione la
possiamo trovare, ad esempio, nel famoso dibattito Chomsky – Foucault sembra
andare in scena l’annosa questione del rapporto tra natura e cultura. Un nodo
centrale del problema è proprio il linguaggio. Chomsky parla di “grammatica
universale” e di “natura umana”. Foucault invece sostiene, più o meno, che la
natura umana è un costrutto storico-politico. Se da una parte l’impostazione di
Chomsky sembra lasciare poco spazio alla differenza (sessuale, ma anche culturale),
dall’altra l’approccio di Foucault rischia di rendere i “discorsi” l’unico
elemento determinante della realtà. In questo secondo approccio, caratteristico
del post-strutturalismo, i linguaggi non diventano quello che l’economia è stata
per il marxismo, cioè l’unica categoria che conta e definisce la realtà? Esiste
uno spazio fuori dalla produzione di segni, qualcosa di pre-linguistico o
extra-linguistico? Se esiste, può essere una risorsa per l’azione politica? I
corpi del discorso foucaultiano non finiscono con l’essere mera passività
plasmata dai discorsi? Cos’è che può creare una sorta di attrito rispetto ai
discorsi dominanti, permettendo così di prendere coscienza del loro potere
coercitivo e di avviare di conseguenza un movimento di resistenza?
